Piazza Selinunte è un articolo difficile. Si rischiano di scrivere delle ovvietà tremende, senza andare veramente a fondo.
Innanzitutto, una premessa: piazza Selinunte è un luogo di Milano. Inserito nel quartiere San Siro. Quartiere sviluppato nel dopoguerra, ubicato in una zona che era la periferia della periferia, circondato da campi e da fossi. Uno dei vittoriosi esempi di welfare alla milanese: case popolari (quelle basse a 4 piani, come se ne vedono uguali in tante altre periferie, di Milano e non solo) e servizi. Scuole, asili, mezzi pubblici. In lontananza, lo stadio, di cui si odono le grida durante le partite o le musiche durante i concerti.
In piazza Selinunte sorgeva dapprima una scuola, sostituita poi dalla caldaia centralizzata dell’enorme quartiere di case popolari. Case popolari che hanno ospitato, nell’ordine, la povertà del dopoguerra, la portentosa immigrazione meridionale, ed infine, già dagli anni ’80, le nuove povertà del nordafrica. Già anni orsono, la scuola elementare di Via Paravia balzò alle cronache, per aver ospitato, nell’anno scolastico, un solo studente “indigeno” (nel senso di italiano, figlio di genitori italiani).
Via Micene, via Mar Jonio, via Civitali: case scrostate, molte senza ascensore, popolate da lavoratori e operai, fino agli anni ’80: poi, avviene un’importante sostituzione, elemento cruciale nella nostra analisi.
I lavoratori invecchiano e San Siro diventa un quartiere di pensionati: per la prima volta, non c’è un ricambio. Il tenore degli italiani è aumentato, e chi lavora, chi ha un reddito, si rivolge al mercato immobiliare privato. Cosa importante: cambia la percezione. In questo momento storico, a cavallo con l’arrivo dell’immigrazione nordafricana, la casa popolare si fa ghetto, luogo da evitare.
E l’immigrazione si fa ghetto nel ghetto, nel quadro di un disinteresse importante delle istituzioni. Le battaglie per la casa sono ormai prerogativa dei centri sociali e poco altro, la politica ha cambiato linguaggio, la sinistra sta completando la sua complessa trasformazione.
Dunque, né i nuovi immigrati hanno la capacità di organizzarsi autonomamente, né il circostante è in grado di assorbire le loro istanze, creando una sacca di isolamento, all’interno del quale, poco a poco, si crea un mondo “altro”.
Facciamo un salto di qualche decennio ed arriviamo ai giorni nostri. Proviamo a vedere gli ingredienti:
la pandemia; i social network; gli smartphone e l’iperconnettività; la ghettizzazione delle case popolari e della povertà; le enormi difficoltà di integrazione per gli immigrati di prima generazione; il vento politico degli ultimi 30 anni, focalizzato su un ipotetico centro, che tende a tagliare le fasce esterne; alcuni modelli culturali globali molto radicati tra le persone più giovani, che tendono ad esaltare la ricchezza, il successo sociale ed un certo machismo di ritorno.
Semplificando all’osso: quella che un tempo era la classe operaia, dotata di una propria “coscienza” e rappresentanza politica specifica, si dissolve. Le frange più deboli della società sono frammentarie e frammentate, spesso coincidenti con l’immigrazione. L’isolamento e la cultura della strada, quella cantata dal rap di ieri e dalla trap di oggi, creano un sistema che si autoalimenta.
Chi è povero (o si sente tale), se non si annulla, cerca riscatto. Il riscatto, quando non è dei singoli, diviene storicamente fenomeno sociale. E se, come in questi anni, la cultura individualista è quella dominante, il riscatto passa dai soldi, la potenza, la sottomissione degli altri.
Dunque, lo spaccio, la violenza, la conquista divengono forme di avanzamento sociale. Il machismo, la scarsa considerazione della donna e delle persone più deboli sono il sentimento comune.
Se ci aggiungiamo l’isolamento sociale della pandemia e l’effetto amplificatore dei social, la ricetta si fa micidiale. In un mondo chiuso per Covid (la gestione sociale della pandemia è stata pessima, non ha fatto altro che emarginare ai massimi livelli coloro che erano più deboli), la violenza diviene la cifra espressiva più significativa.
Le persone giovani sono quelle che maggiormente soffrono di questa emarginazione, perché c’è un codice genetico, una dotazione ormonale che si mette di traverso: c’è la necessità di esprimersi per autoaffermarsi. Ma tutto è bloccato, vietato, bandito. Il mondo sembra immobile, e sordo. E allora, scatta l’ansia, la rabbia. Emerge la voglia di distruggere tutto, scatta quel sentimento primordiale di assoggettare gli altri alla propria volontà, per mostrare la propria forza ed invincibilità, in un mondo sempre più annichilito e diviso.
Qualcuno giustamente mi rimprovererà, mi dirà che sto glissando, mi parlerà del radicalismo di matrice araba, delle banlieue francesi (che, non a caso, sono un modello giovanile molto forte, e la trap francese è tra le più belle e seguite). Ne sono consapevole, un po’ come fu la cultura della mafia nell’emigrazione italiana in america, così ben descritta da un’importante cinematografia, che l’ha resa addirittura eroica. Tutto vero.
Ma le violenze e i regolamenti di conti a Piazza Selinunte, le sparatorie, le rapine dei trapper italafricani, egiziani, marocchini, tunisini di seconda e terza generazione, non sono di origine etnica, né di origine religiosa. Quantomeno, non lo sono in modo prevalente.
Mentre il mondo degli adulti si sforza di essere sempre più “correct” ed è impegnato a rimuovere buona parte della propria cultura, perché ritenuta scomoda, il mondo dei giovani affonda in una neo-arretratezza di rimando. Un mondo manicheo, fatto di piccolo spaccio, di sirene della polizia, di ragazze mostrate come vanto (bitches, all’americana, è l’epiteto), di muscoli mostrati come trofei, di risse in favore di social, di stupri e violenze di massa. Dalle baby gang a Baby Gang: un termine coniato per descrivere una forma di devianza sociale diventa il nome di un rapper, reale, autentico, che canta la violenza perché la pratica. L’artista delinquente di Piazza Selinunte.
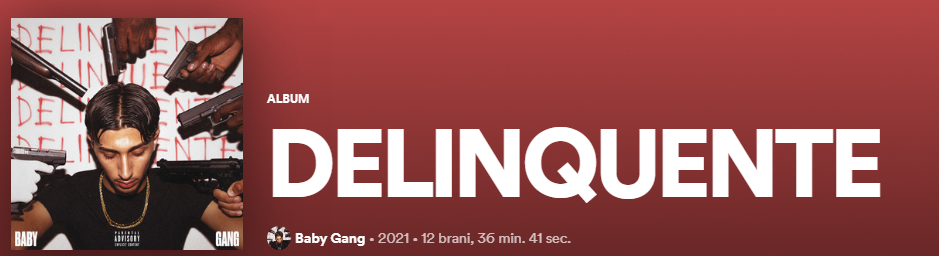
La cosa che più mi ha colpito guardando il servizio sul famoso video di Neima Ezza girato tra quelle case popolari in pieno lockdown è l’immagine di un giovane schiumante rabbia che grida “vecchio di merda” ad un abitante che si stava lamentando per il caos.
In questo insulto, identifico il peccato originale della società contemporanea: l’aver diviso le generazioni. E se dovessi, io, pensare a come curare il male di una società che non collabora, partirei proprio da questo punto. L’unico spiraglio di salvezza è creare un ponte generazionale. La vetrina dei giovani arrabbiati non può essere (solo) quella social. Ma, per aprire un fronte di dialogo, c’è una sola modalità: la costruzione della fiducia. Entrare nei quartieri alla pari, e restituire servizi. Interrogarsi sui bisogni. Mettersi in ascolto.
Nessuna ricetta facile. Chiudo proprio con alcune barre di Gang. Mettersi in ascolto. Farlo subito.
Vengo da Milano, Milano, Milano
Dove ti rubano, rubano, rubano, rubano
A Milano, sì, pure la mano
Con me non ci prova, sai come mi chiamo?
Solo a tredic’anni sui telefonini
Facevo affari dentro Maciachini
Saltavo la metro, andavo in Duomo
Entravo, rubavo, fra’, tutti i vestiti, gang
Chop-chop, ghiri-ghiri, fuck trap, giro e muovo chili
Fuck Trump e Salvini, fuck rap dei kilimini
Gang-gang dei bambini, bamba e dei latini
Zatla marocchina, fa-faccio una rapinaKhoya, come va-va? Sto con Toto e la fa-fa
Alo, pronto, come va-va? Baida buona, mon amour
Khoya, come va-va? Wesh, mon poto, ça va pas-pas
Koulshi mghanzer Casablanca, zatla buona, mon amour

